di Tiziana Albanese e Lanfranco Caminiti
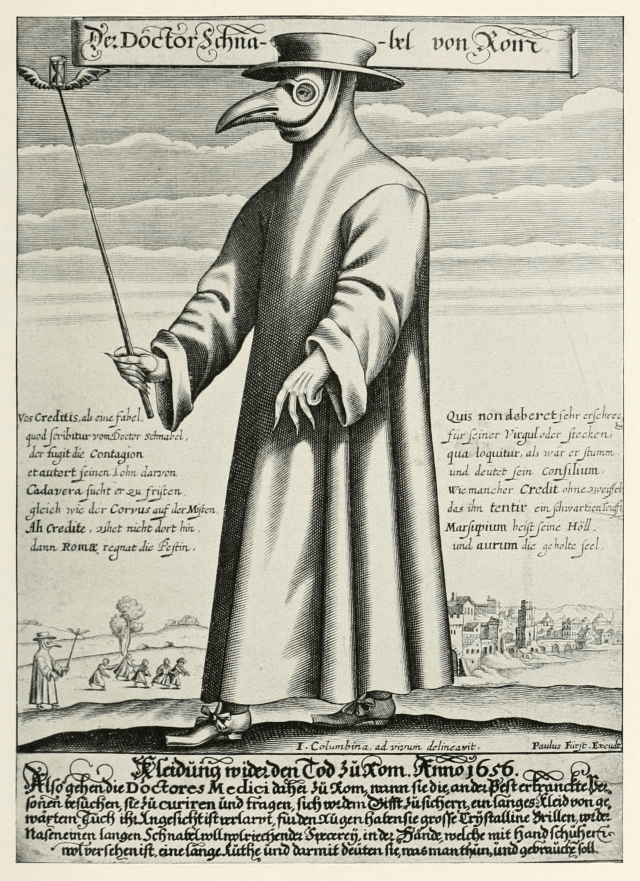
I fatti: con una lettera aperta – primo firmatario Giovanni Ruffino, Accademico della Crusca e presidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani – linguisti e dialettologi delle Università di Palermo, Messina e Catania si sono rivolti al Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Madonie, che avrebbe discusso una mozione giorno 20 maggio perché la lingua siciliana venga riconosciuta come lingua ufficiale della Regione, e anche a tutti i Comuni (sono già diciotto i comuni che hanno firmato il Manifesto per la lingua siciliana) che hanno già approvato la mozione, per «ritirarla in autotutela». Le motivazioni starebbero nel fatto che «quando si costruisce una strada si chiede la progettazione ad un ingegnere, quando si ritiene di dare centralità ad un sistema linguistico sarebbe bene ascoltare gli specialisti» (ovvero: loro), mentre invece la proposta è portata avanti da «associazioni prive di autorevolezza scientifica» probabilmente mosse da «convenienze ideologiche». Il 20 maggio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Madonie ha deciso di rinviare la discussione sulla mozione. Intanto, all’assemblea Regionale Siciliana il 16 maggio 2025 è stato presentato, dai deputati: on.li Lombardo Giuseppe Geremia, Di Mauro, Carta, Balsamo, un Disegno di Legge (n. 945) dal titolo: Schema di disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione recante: Disposizioni per il riconoscimento e la tutela della lingua siciliana.
- Perdennu na corda lu jornu.
Se il siciliano, dialetto o lingua che sia, si riducesse anno dopo anno a essere uno strumento di comunicazione verbale sempre più circoscritto tra pochi parlanti dell’isola, il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, con il suo vasto corredo di pubblicazioni, ricerche, volumoni e cattedre, continuerebbe imperterrito e indefesso il suo lavoro, la sua esistenza – anzi, la accrescerebbe: non è questo forse quanto accade per le lingue morte, il greco, il latino, un proliferare di cattedre e concorsi e convegni e incontri internazionali e premi e riviste?
È questo perciò il paradosso: il siciliano è una lingua morente (vulnerabile, la considera l’UNESCO, con un eufemismo) ma il Centro studi filologici sul siciliano è un’attività fiorente.
Ora, benché ci sia una relazione diretta e inoppugnabile fra le due cose (il siciliano che muore e l’attività del CSFLS che fiorisce) non vogliamo certo dire che sia colpa del Centro studi se il siciliano va morendo: la nostra personale, dilettantesca opinione è che il siciliano vada scomparendo perché sono andate scomparendo centinaia di figure del lavoro in Sicilia, con la loro gergalità, le parole specifiche per indicare lo svolgersi della loro attività, gli strumenti, gli oggetti, la mobilità: pensiamo soprattutto al mondo delle campagne, al ciclo delle stagioni e della semina e del raccolto, o a quello della pesca, agli allevatori, agli artigiani, agli ambulanti, ai mercati rionali o nei paesi, ai commercianti delle fiere. Un mondo che va in estinzione, con le loro “parlate”; spesso diverse da luogo a luogo – basterebbe pensare a come lo stesso pesce veniva “nominato” diversamente lungo le costiere rivierasche della Sicilia dai suoi pescatori – e da “vallo a vallo”, anche se questo non ha mai impedito la comunicazione e lo scambio.
Le modificazioni del lavoro – profonde, profondissime – e quelle della “forma” della famiglia – il ruolo della donna, lingua-madre, nella cura della crescita dei figli e delle attività domestiche, della preparazione del cibo, o il ruolo dei nonni, nella trasmissione di memorie, di saperi e di parole – come d’altra parte l’urbanizzazione, la scolarizzazione (con i suoi test INVALSI!), la “vita sociale” con il ruolo preponderante delle tecnologie per la comunicazione, hanno drammaticamente stravolto l’uso comune della lingua in Sicilia.
La lingua materiale – le parole che nominavano le cose che non ci sono più – va quindi progressivamente eclissandosi; e per le “cose nuove” – la playstation e i videogame, l’hamburger e il ketchup, i social e i talk-show e i reality, i leader e le convention – ci sono gli anglicismi. - Arripizzannu a tila camulata.
La cosa che vogliamo dire è perciò un’altra: mentre il siciliano, lingua o dialetto che sia, muore, il presidio occhiuto del Centro studi – una vera impresa titanica – non serve minimamente a impedirlo: se a una figura retorica possiamo accostarlo è a quella del prete che salmodia litanie nella stanza dell’agonizzante.
A che titolo perciò – quali risultati sul campo, quali medaglie, quali coppe può sollevare nell’avere impedito nei suoi gloriosi anni di duro lavoro che il siciliano continuasse a scomparire – il Centro di studi filologici e linguistici siciliani ha alzato le barricate, ha lanciato i suoi anatemi, ha intimato l’apocalisse contro il DDL 945 presentato all’Assemblea regionale Siciliana? A che titolo, con i loro «corsi di dialettologia storica, di usi sincronici delle varietà dialettali, conoscenza e analisi degli autori della più grande tradizione letteraria, promuovendo convegni, laboratori sul campo, corsi di formazione per docenti, ricerche lessicografiche, onomastiche, geolinguistiche, collane editoriali sulle singole varietà dialettali e sulle varietà alloglotte»? Zero tituli – questo è il triste dato.
Si dirà – noi stessi lo abbiamo detto – ci sono questioni strutturali, processi storici, interventi da compiere che non hanno alcuna pertinenza con il lavoro del linguista, con l’attività del Centro studi. Il quale sostanzialmente si trincera dietro questa osservazione: la lingua si preserva nelle famiglie, e se nelle famiglie non si parla più in siciliano – noi che ci possiamo fare? E il punto è proprio questo: il riconoscimento, la valorizzazione, la tutela del siciliano è una questione sociale, è una “questione politica”: non di questa o quella politica, ma della politica. Perché è la politica, l’interesse collettivo per la cosa pubblica (e quale “cosa pubblica” c’è, più pubblica della lingua?) – e l’amministrazione, ovvero “la messa a terra” delle disposizioni in un articolato e capillare fare – che ha gli strumenti e i mezzi e, soprattutto, il “mandato popolare” per intervenire. Non è la politica che interviene sulle questioni della sanità? Non è la politica che interviene sulle questioni della mobilità? O è l’ordine dei medici e quello degli ingegneri? E basta davvero con questo avvilente e mortificante paragone del “se si deve sistemare un rubinetto, si chiama un idraulico”. La politica, l’interesse collettivo per la cosa pubblica, interviene sulle questioni di emergenza e sulla programmazione: e la questione della scomparsa del siciliano come lingua regionale non è un’emergenza? Non ha bisogno di programmazione? - I minni a funtani di latti.
Perché tutto questo? si chiede il professor Ruffino. Gli risponderemo con la sua stessa citazione, tratta da Ignazio Buttitta: «preservare la “lingua addotata dai patri”».
Certo, per chi considera il siciliano all’incirca come le tavolette assiro-babilonesi in scrittura cuneiforme su cui è riportato il Codice di Hammurabi – tutto questo può suonare come una “invasione di campo”, un atto di lesa maestà: sono loro i “tenutari” della lingua, i suoi sacerdoti. Che è una cosa bizzarra, va detto: come se Zanichelli, che ogni anno aggiorna il dizionario della lingua italiana, con i neologismi che la società “costruisce”, si sentisse il suo “proprietario” e non l’estensore.
Invece di agitare lo spettro di uno «spaventoso aggravio», una débâcle formativa (che ne sarà dei test INVALSI?!) per i nostri bambini – ai quali, nelle scuole, accade di essere “disincentivati”, diciamo così, dall’uso del siciliano e “incentivati”, diciamo così, all’uso esclusivamente dell’italiano, perché questo è il “quadro normativo” e la routine, dentro cui di sicuro operano all’inverso validi singoli docenti – e disegnare foschi scenari di autonomismo, indipendentismo, secessione, e del minaccioso tono usato e del disprezzo sparso a piene mani contro le «associazioni prive di autorevolezza scientifica», sarebbe più generoso, da parte dei nostri stimatissimi accademici del Centro studi, mettere a disposizione di questo percorso l’enorme accumulazione di saperi e competenze. Ci si sarebbe aspettati una disponibilità diversa nel riscontrare che non solo altri esperti ma cittadini comuni, con responsabilità e passione, si impegnano per porre un argine all’estinzione del siciliano. Ci si sarebbe aspettati una apertura diversa nel constatare che istituzioni locali e l’Assemblea regionale stanno facendo propria questa dinamica di valorizzazione della lingua siciliana.
A meno che poi – come la professoressa di glottologia e linguistica Iride Valenti, che si è scagliata anch’ella lancia in resta contro il DDL – non si contentino del fatto che, nel numero 3608, uscito lo scorso 15 gennaio, in una storia Topolino parli catanese. Perbacco! - A nota vascia du sonu e du lamentu.
Il timore espresso dai linguisti e dialettologi firmatari della intimante missiva è che si intenda «imporre una alchemica lingua scritta», un “modello” che finirebbe con il provocare «la condanna a morte delle parlate locali»: rimarrebbe da capire perché i sardi che, come noi, hanno una «storia di integrazioni, inclusioni, ma anche differenziazioni tra aree» – basterebbe pensare alle differenze linguistiche tra Cagliari e Nuoro e Sassari – abbiano invece approvato una legge (Legge Regionale 3 Luglio 2018, N. 22) dal titolo: Disciplina della politica linguistica regionale, il cui art. 1 recita così: «La Regione assume l’identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale».
Per linguisti e dialettologi delle Università siciliane invece non può esistere una lingua regionale perché la Sicilia non ha una identità regionale, ma vive delle sue differenze locali; se a qualcosa di più grande appartengono, queste differenze locali, è all’Italia.
È in nome di questo esasperato “localismo idiomatico” che gli accademici si sono messi di traverso.
Che non è propriamente un gran bel vedere.
25 maggio 2025.
leggi anche:
Risciacquare i panni in Oreto.
Mordendosi la lingua.

